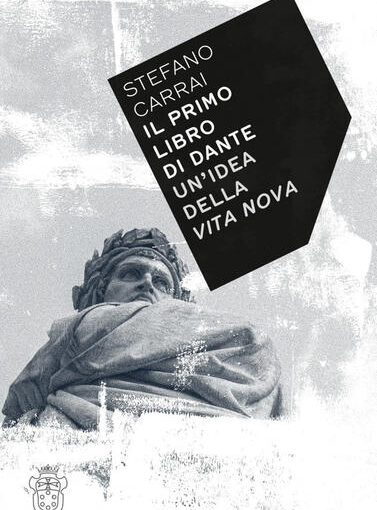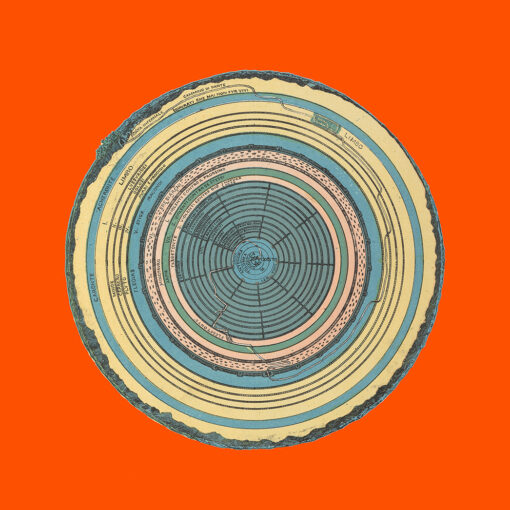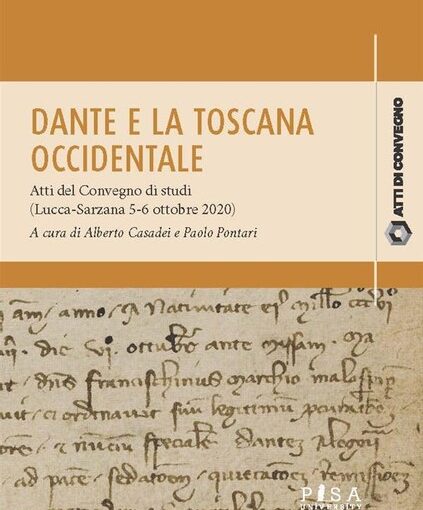Si ringrazia il prof. Floriano Romboli per aver concesso la pubblicazione di questo suo contributo, destinato alla rivista padovana “La Nuova Tribuna Letteraria”.
Incontri con Dante e la Commedia : la lettura critica di alcuni interpreti di grande autorità culturale
La più evidente peculiarità di un classico della letteratura è nella capacità di resistere al tempo, imponendo infine la persistente attualità del proprio messaggio ideale e culturale-artistico. Riguardo alla Commedia lo sottolineò con lucidità sintetica Gianfranco Contini (1912-1990) a conclusione di un suo celebre saggio, Un’interpretazione di Dante, occasionato dal secondo centenario novecentesco, apparso nell’ottobre 1965 sulla rivista “Paragone” e poi accolto nel volume einaudiano Varianti e altra linguistica (1970): “ La sua lontananza è insieme controprova e garanzia della sua vicinanza vitale. L’impressione genuina del postero, incontrandosi con Dante, non è d’imbattersi in un tenace e ben conservato sopravvissuto, ma di raggiungere qualcuno arrivato prima di lui”.
Giova tuttavia non dimenticare l’ambivalenza insopprimibile e quindi la ricorrente contraddittorietà insite nei percorsi storici: ne risente altresì la “fortuna” degli scrittori, pure grandissimi, che di rado conosce la linearità positiva di un consenso costante e univoco, di un grado pari di unanime ammirazione. Relativamente al capolavoro del poeta fiorentino è ad esempio di manualistica notorietà la stroncatura risentita fattane dal gesuita mantovano Saverio Bettinelli (1718-1808), alla luce dell’idea-valore di un’arte classicisticamente regolata e razionalmente composta, soprattutto nella seconda e terza delle Lettere virgiliane (1757). Si sa che Voltaire (1694-1778) aveva definito il poema di Dante salmigondis (guazzabuglio) pesante e oscuro, e il letterato italiano metteva in risalto le sue caratteristiche irrimediabilmente negative con impietosa perentorietà (“Io sfido il poeta scitico e geta più barbaro, che mai cantasse in riva de’ mari glaciali, a parlar più basso, più duro, più falso, più freddo che non fa Dante in tanti luoghi”, Lettera terza), optando nondimeno per un declassamento inequivoco, ma svolto in termini più distaccati e briosamente faceti: “Oh che sfinimento non fu per noi lo strascinarci, per cento canti e per quattordici mille versi, in tanti cerchi e bolge, tra mille abissi e precipizi con Dante, il qual tramortiva ad ogni paura, dormiva ad ogni tratto, e mal si svegliava, e noiava me, suo duca e condottiere, delle più nuove e più strane dimande che fosser mai (…) Rileggete con questa riflessione quell’imbroglio non definibile, e poi mi direte che ve ne sembri”, Lettera seconda, cors. mio).
I manuali informano anche dello “scandalo” suscitato da tale aggressivo intervento critico; in realtà l’autore sfondava la classica porta aperta: a ben vedere non sfidava alcuna tradizione, ma secondava un orientamento culturale sfavorevole alla Commedia invalso da almeno due secoli. Con l’affermarsi della proposta letteraria (interpretativa e programmatica) di Pietro Bembo (1470-1547), privilegiante nettamente il modello petrarchesco, si dette un rapido, crescente ridimensionamento del “culto” di Dante, che si obiettivò, già nella seconda metà del Cinquecento, nel commento del grammatico, traduttore ed erudito modenese Lodovico Castelvetro (1505-1571), il quale nella Spositione a XXIX canti dell’Inferno, risalente agli anni 1569-1570, considerava la prima cantica sulla falsariga dei criterî di verosimiglianza, di ragionevolezza e di convenienza (è il prépon degli antichi greci) delle situazioni intellettuali-morali desunti dalla Poetica aristotelica, e ne circoscriveva il valore, limitandone l’esemplarità in quando documento artistico di un’epoca passata.
Per un ritorno significativo d’attenzione al poema saranno necessarî la riflessione filosofica di Giambattista Vico (1668-1744) e il concetto a essa consustanziale del “poeta primitivo” che l’ Alighieri meravigliosamente incarnava, nell’àmbito del sistema teorico della Scienza Nuova (la cui prima edizione è del 1725): il pensatore napoletano si incaricava in particolare di fissare la specificità tipologica di esso – decisiva per la futura estetica romantica – nella nota lettera scritta il 26 dicembre 1725 al giovane allievo e promettente poeta Gherardo Degli Angioli (1705- 1783) : “In seno alla fiera e feroce barbarie d’Italia (…) dovette fra
gl’Italiani ritornar la lingua muta, (…) con cui i loro autori, innanzi di trovarsi le lingue articolate, dovettero spiegarsi a guisa di mutoli, per atti o corpi aventi o no naturali rapporti all’idee, che allora dovevano essere sensibilissime, delle cose, che volevan essi significare; le quali espressioni vestite appresso di parole vocali, debbono aver fatta tutta l’evidenza della favella poetica”.
Naturalità, libertà fantastico-immaginativa, schiettezza e profondità etico-sentimentali, spontaneità anti-intellettualistica saranno ritenute nell’Ottocento romantico requisiti primarî, qualità necessarie di ogni forma d’arte autentica e vera : la condivisione diffusa di siffatte coordinate estetico-culturali fu alla base di un abito mentale che appartenne altresì a uno studioso del prestigio di Francesco De Sanctis (1817-1883), il quale nel capitolo settimo della meritamente famosa Storia della letteratura italiana – pubblicata a Napoli dall’editore Antonio Morano nel marzo 1871 – propose una lettura organica e incisiva del testo dantesco, una prima, moderna sistemazione critica, una puntualizzazione ragionata dei valori poetici di quell’opera tanto rilevante.
Lo studio desanctisiano è percorso da viva ammirazione per la Commedia, di cui rileva con forza l’importanza letteraria e la centralità pure civile, a causa dell’insolita ampiezza della materia, nella vicenda storica della nostra nazione (“E’ una di quelle costruzioni gigantesche e primitive, vere enciclopedie, bibbie nazionali, non questo o quel germe, ma il tutto, che contiene nel suo grembo ancora involute tutta la materia e tutte le forme poetiche, il germe di ogni sviluppo ulteriore (…) E’ il contenuto universale, di cui tutte le poesie non sono che frammenti, il “poema sacro”, l’eterna geometria e l’eterna logica della creazione ne’ tre mondi cristiani”), ma è sotteso da un’ottica dualistica incardinata sulla contrapposizione fra l’impianto dottrinale, la concezione allegorica tipica del Medio Evo – assunto eminentemente anti-poetico – e la poesia concretamente realizzata, indipendentemente, anzi antagonisticamente rispetto all’intento originario, giacché “se l’allegoria ha reso possibile a Dante un’illimitata libertà di forme, gli rende d’altra parte impossibile la loro formazione artistica. Dovendo la figura rappresentare il figurato, non può essere persona libera e indipendente, come richiede l’arte, ma semplice personificazione o segno d’idea (…) L’allegoria dunque allarga il mondo dantesco, e insieme lo uccide, gli toglie la vita propria e personale, ne fa il segno o la cifra di un concetto a sé estrinseco. Hai due realtà distinte, l’una fuori dell’altra, l’una figura e adombramento dell’altra, perciò amendue incompiute e astratte”.
Avvalendosi di uno strumento critico-metodologico ricorrente nelle sue pagine – la diade “mondo intenzionale/ mondo effettivo” (“Sicché nella Commedia, come in tutti i lavori d’arte, si ha a distinguere il mondo intenzionale e il mondo effettivo, ciò che il poeta ha voluto e ciò che ha fatto (…) Il poeta si mette all’opera con la poetica, le forme, le idee e le preoccupazioni del tempo; e meno è artista, più il suo mondo intenzionale è reso con esattezza”, corsivi miei) – , De Sanctis registra tuttavia il “miracolo” della poesia di Dante nell’atto di affermazione, da parte di quest’ultima, della propria autonomia lirico-rappresentativa a petto delle sollecitazioni eteronome e subordinanti del progetto filosofico, ideologico-religioso: “Era poeta e si ribella all’allegoria. La favola, ciò ch’egli chiama bella menzogna, lo scalda, lo soverchia, e vi si lascia ir dietro, come innamorato, né sa creare a metà, arrestarsi a mezza via (…) La realtà straripa, oltrepassa l’allegoria, diviene sé stessa; il figurato scompare, in tanta pienezza di vita, fra tanti particolari”.
Armato di rigore speculativo di ascendenza hegeliana, lo studioso irpino predilige poi la “vita piena e corpulenta” dell’Inferno, ove “la vita terrena è riprodotta tal quale”, mentre “spiritualizzandosi negli altri due mondi diviene povera e monotona”; coerentemente egli tiene in particolare pregio le grandi individualità del primo regno (Francesca da Rimini, Farinata degli Uberti, Ulisse, il conte Ugolino), stante il suo accoglimento di una scoperta gerarchizzazione valutativa delle tre cantiche, secondo un atteggiamento da secoli tradizionale presso i lettori e spesso ritornante nella “fortuna” di Dante. Ciò non gli impedisce comunque di analizzare con perspicacia aspetti della poesia del Purgatorio e del Paradiso; non sorprende però che le bellezze “liriche” nella raffigurazione del mondo dei beati siano ricondotte alla terrestrità, al naturalismo descrittivo, all’uso frequente della figura della similitudine : “Così rientra la terra in paradiso, non come sostanziale, ma come immagine, parvenza delle parvenze celesti. E’ la terra che rende amabile questo paradiso di Dante; è il sentimento della natura che diffonde la vita tra queste combinazioni ingegnose e simboliche (…) Questi paragoni di Dante sono le vere gemme del Paradiso ”.
Ancora un marcato dualismo caratterizza la monografia che Benedetto Croce (1866-1952) dedicò soprattutto alla Commedia nel 1921 – quindi nella circostanza del primo centenario del Novecento – , e che non casualmente volle intitolare La poesia di Dante.
Al filosofo napoletano il poema appare un potente organismo unitario, perché basato sull’unitarietà e sulla solidità di una concezione della realtà sulla quale verso la fine del libro egli si sofferma con rara efficacia caratterizzante: “Che cosa è, dunque, questo spirito dantesco, l’ethos e il pathos della Commedia, la “tonalità” che gli è propria? E’… un sentimento del mondo, fondato sopra una ferma fede e un sicuro giudizio, e animato da una robusta volontà. Quale sia la realtà, Dante conosce, e nessuna perplessità impedisce o divide e indebolisce il suo conoscere, nel quale di mistero è solo quel tanto a cui bisogna piegarsi reverente e che è intrinseco alla concezione stessa, il mistero della creazione, provvidenza e volontà divina, che si svela solo nella visione di Dio, nella beatitudine celeste”.
A dispetto della sua compatta organatura intellettuale, morale e sentimentale, l’opera nondimeno è contrassegnata dalla manifesta compresenza, accanto all’opus poëticum, di un opus philosophicum e di un opus practicum costituiti da “atti di fede e di religiosità, insegnamenti, censure, della politica fiorentina e di quelle della Chiesa e dell’Impero e di tutti i principi italiani e forestieri, sentenze e vendette, annunzî e profezie”; più precisamente l’universo ideale di Dante si esplicita altresì attraverso preoccupazioni allegoriche, didascaliche, teoricistiche e classificatorie, che danno vita a quel “romanzo etico-politico-teologico” determinante la complessa cornice architettonica, la tanto articolata organizzazione topografica che fanno da sfondo e sostengono e scandiscono il viaggio oltremondano dell’autore.
Tutto questo, secondo Croce, è struttura, parte non poetica, materia “allotria” ed estranea a una corretta comprensione e a un godimento sincero dell’arte dantesca, la quale vive nei momenti “lirici”, eterogenea e pertanto incompatibile con le sottigliezze erudite e le astruse quaestiones coltivate nel tempo con impegno degno di miglior causa dal puntiglio pedantesco di tanti commentatori: è piuttosto necessario considerare “le parti strutturali della Commedia…non prendendole come schietta poesia, ma neppure respingendole come poesia sbagliata, sì invece…rispettandole come necessità dello spirito di Dante, e poeticamente soffermarsi in altro”.
Mette conto porre in risalto la differenza fra la posizione crociana e quella del De Sanctis: nell’analisi di questi le forme allegoriche comprimono la poesia fino a soffocarla, ne rappresentano la negazione tout court; in Croce la struttura – nel quadro della sua filosofia, che è stata definita “dei distinti” – è soltanto un elemento neutro ed esteticamente indifferente, extrapoetico, secondo che risulta dalla piuttosto conosciuta similitudine: “Paragone per paragone, si potrebbe piuttosto raffigurarla come una fabbrica robusta e massiccia, sulla quale una rigogliosa vegetazione si arrampichi e stenda e s’orni di penduli rami e di festoni e di fiori, rivestendola in modo che solo qua e là qualche pezzo della muratura mostri il suo grezzo o qualche spigolo la sua dura linea”.
Non è certo il caso di disconoscere l’importanza storica del saggio, così chiaro e ben argomentato, dell’autorevole pensatore; preme al tempo stesso segnalarne i limiti, che consistono nell’atomizzazione del testo ridotto a un’antologia, magari ampia, di “perle liriche” prive di alcuna vitale connessione estetica con la cornice strutturale dell’oltretomba, la quale a suo modo illumina e conferisce significato assoluto e densità escatologica alle vicende pur storiche dei personaggi. Inoltre l’insofferenza per le indagini ispirate a erudizione oziosa può pericolosamente trasformarsi in pregiudizio anti-filologico, come nel caso del verso – indubbiamente di non agevole interpretazione – del “disdegno di Guido” nel decimo canto dell’Inferno, ove Croce arriva paradossalmente a consigliare l’abbandono di ogni ulteriore ricerca ermeneutica, perché “in quella insistenza sopra un verso oscuro (viene smarrendosi) la poesia dell’episodio, che è chiarissima”.
Occorre d’altronde non trascurare il fatto che nella lettura puntuale delle cantiche egli recupera ai valori della poesia tante parti semplicisticamente e colpevolmente trascurate, come quelle animate dalla “poesia didascalica”, in quanto “il motivo che vi domina non è l’indagare e l’insegnare che la mente opera, ma la rappresentazione dell’atto dell’indagare e insegnare, la virtù di quest’atto, che si compiace e gioisce di sé stessa”. Ne discende, con palese consequenzialità, il rifiuto del “volgare giudizio onde si nega virtù poetica al Paradiso” di cui si rivendica la liricità diversa, ma non inferiore.
In tempi più recenti un illustre studioso della letteratura italiana come Mario Fubini (1900-1977), nel corso delle sue lezioni sulle forme metriche tenute all’Università Statale di Milano intorno alla metà degli anni Cinquanta e pubblicate successivamente nel volume Metrica e poesia (1962), sottopose a un esame accurato ed esauriente la terzina dantesca, quella strofa di tre endecasillabi a rima incatenata ( e quindi più che singola strofa, serie di strofe) della quale acutamente evidenziava l’indubbia originalità (“Il metro della Divina Commedia ci si presenta per la prima volta soltanto nel poema”), pur concentrandosi, con essenziale, ma persuasiva ricerca diacronica, sui precedenti e pertanto sulla genesi di essa.
Il critico la riconduce innanzitutto alla tradizione del sirventese, alle sue caratteristiche quasi “giornalisticamente” informative ed enumerative, dalle cadenze popolareggianti e un po’ monotone ( e in questo lontane dalle esperienze della lirica elevata, raffinatamente sostenuta della “canzone”), tuttavia intrinsecamente dotate di respiro narrativo, a cui conviene aggiungere i componimenti didattici di un Giacomino da Verona, di un Bonvesin de la Riva, incluso il Tesoretto dell’amato maestro Brunetto Latini:
“Dante però, fin dall’inizio, ha una trovata geniale: non il settenario ma l’endecasillabo, non le rime baciate ma alternate, con il concatenamento delle strofe suggerite dal sirventese e dalla pratica delle terzine del sonetto e, mentre l’insistenza di queste rime era simile all’insistenza della poesia didattica descrittiva, l’elemento di varietà era dato dalle rime non più uguali, ma alternate”.
Fubini sottolinea poi l’influenza, ai fini dell’adozione del metro suddetto, delle solide nervature logiche del sillogismo scolastico, dell’articolazione ternaria connaturale all’aristotelismo medievale operanti anche al livello delle scelte linguistiche, inducendo la spiccata propensione a un discorso sintattico ricco di nessi quali però, ché e simili, e innervato dalle congiunzioni e, ma, tanto, quanto, che “sono…altrettanti punti d’appoggio” della versificazione. Perciò “la terzina non rimase più un metro terra terra, ma si rivelò capace di qualsiasi effetto, divenne una cosa sola” con lo spirito di Dante, in quanto “la tensione di una terzina chiama l’altra, il fatto della rima del secondo verso raccolta dalla terzina seguente non è più un espediente mnemonico o meccanico, ma esprime un legame genetico”; esprime in particolare la peculiare forma mentis dell’Alighieri, aperta e chiusa ad un tempo, perché governata dalla duplice necessità di accogliere senza limiti la vivace molteplicità del reale, e insieme comprenderla, con sicura sapienza ordinativa, entro quadri cognitivi e assiologici saldi e indiscutibili: “Il dinamismo della terzina dantesca risulta dal contrasto tra la robusta costruzione intellettuale e la forza passionale, anche sensuale, che tende a fissarsi sopra tutto nella parola in rima”, in un moto costante di transizione dal particolare all’universale e viceversa.
“Massima necessità all’esterno, massima libertà all’interno: si riproduce anche qui la formula del comportamento di Dante; e il metro deve consentire il passaggio agevole dall’una all’altra velocità, dall’uno all’altro stato, l’eterno, permanente e universale, il momentaneo, imprevedibile ed estroso”.
Con queste parole, circa un decennio dopo, il filologo e critico Gianfranco Contini dichiarava la propria sostanziale concordanza con l’interpretazione fubiniana. Si tratta di affermazioni contenute nello scritto Un’interpretazione di Dante citato all’inizio, che costituisce, insieme all’altro che reca il titolo Dante come personaggio-poeta della Commedia, il caposaldo dei suoi numerosi lavori danteschi, in un certo senso la summa della sua “idea di Dante”.
In questo secondo contributo, cronologicamente anteriore (concepito nel 1957, fu pubblicato nell’ “Approdo letterario” del gennaio-marzo 1958), è già presente il riferimento alla doppia caratteristica, universale e particolare, di colui che nel poema dice “io”: “ Io trascendentale (con la maiuscola), diremmo oggi, e “io”(con la minuscola) esistenziale”; egli è l’uomo in generale e l’individuo storico, l’agens e l’auctor, “savio e profeta, uomo di scienza e in qualche modo uomo d’azione”.
Datoché “il viaggiatore d’oltretomba è uomo di lettere”, il procedere del personaggio può pure configurarsi come “la storia, stavo per dire, l’autobiografia, di un poeta”, e così molti suoi incontri possono essere letti più approfonditamente alla luce delle preoccupazioni filosofico-religiose, secondo i criterî di una concezione profetica, della complessiva visione salvifica, ma altresì giusta il principio di una ricognizione critica e selettiva di modelli letterarî, di un conflitto di poetiche.
Per questo Francesca da Rimini, per quanto sia “un’usufruttuaria delle lettere, quel che si dice una lettrice, non una produttrice in proprio”, è testimone, attraverso la propria esperienza personale, degli esiti di una passione amorosa nutritasi dei loci culturali dello Stil Novo e approdata, in nome della piena libertà sentimentale, alla violazione delle regole morali, dal momento che “l’interpretazione” datane dalla donna “è corporea (“la bella persona”) e la realizzazione adulterina: nulla di più conforme” alla dottrina di Andrea Cappellano, secondo il quale “è escluso, a fil di sillogismi, che l’amore possa essere coniugale”. La “pietate” che sconvolge alla fine il personaggio-poeta vale tuttavia il distanziamento, per quanto doloroso, e il superamento convinto di uno specifico codice ideale.
Lo stesso accade per quel che riguarda altre figure incontrate o menzionate, da Guido Cavalcanti a Forese Donati, da Bonagiunta Orbicciani ad Arnaut Daniel, in un serrato rendiconto intellettuale, sicché “ogni tappa e sosta del suo viaggio oltreterreno è una modalità del suo “io” antico vittoriosamente attraversata, (e) quei suoi interlocutori sono loro, storici, e sono altro, simbolo e funzione”.
Nell’altro contributo lo studioso torna sullo statuto letterario dell’autore, sul suo “carattere bifronte, di individuo ineffabile e di uomo in generale”, per valorizzare però – in questo memore della distinzione crociana fra “struttura” e “poesia” della quale si è in precedenza discorso – le doti di inesausta creatività fantastico-verbale dell’Alighieri a fronte del suo disegno teorico e ideologico: “La cultura di Dante aveva un bel vietargli la presa diretta, la concezione autonoma delle singole invenzioni; proprio del grande poeta è di varcare la restrizione culturale, lasciando un margine illimitato alla collaborazione della cultura avvenire”.
A questo livello si misura e si apprezza l’attualità di chi “linguisticamente è, e già vuole essere, un profeta e un classico”; la sua costante sperimentazione formale-stilistica giunge ad acquisizioni indimenticabili, alla realizzazione di quel “martellante, epigrafico enunciato dantesco, atto a far presa sulla memoria come una citazione classica”, che sa farsi stimolo all’auto-imitazione, risolvendosi in memoria ritmica e timbrica in molti passi dello stesso scrittore.
La mente di Dante non rifiuta alcun dato di realtà, dalla meteorologia alle affascinanti descrizioni naturali, dalle condizioni psicologiche alle operazioni dell’intelletto, in un lavoro di sintesi artistica che “appare un’inaudita novità”.
Contini indugia a un certo punto sul sovente tentato parallelo con il Petrarca: “La realtà, primaria ma generica nel Petrarca, in Dante è esatta, ma subalterna (…) ma occorre riferire questa situazione alla peculiare condizione della libertà nel medio evo. Diversamente che nel mondo moderno, essa si attua con straordinaria elasticità entro un perimetro di assoluta sicurezza, autorità o fede”.
In conclusione egli ritiene che la forza dell’autore della Commedia risieda nella capacità di far valere le sue rappresentazioni per sé, di trasmetterle ai posteri con così coinvolgente potenza, nel contesto di scelte ideali-culturali remote da noi, eppure tanto inclusive da farcelo sentire senz’altro contemporaneo.
Floriano Romboli